
TSM | Cronologia | Onomastico | Glossario | Thesaurus

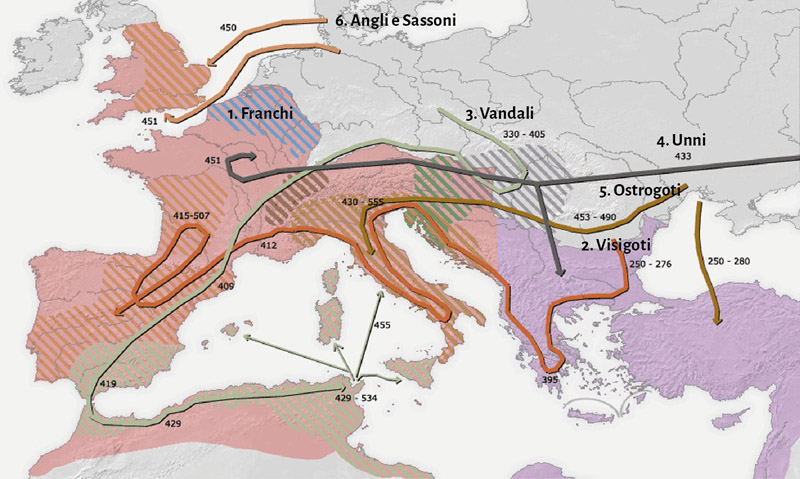
Anche al canto ambrosiano, l'unico sopravvissuto all'unificazione dei riti e vivo ancora oggi nella diocesi di Milano, la tradizione assegnò un autore illustre, secondo la costumanza medievale: S. Ambrogio, uno dei padri della Chiesa, la cui opera musicale è storicamente provata solo per quanto riguarda gli inni; tuttavia i suoi scritti, accanto a quelli del contemporaneo Agostino, lasciano scorgere un vivo interesse nei confronti della musica e un'incisiva azione volta a rendere il canto più ricco sotto il profilo melodico.
Sul canto ambrosiano si esercitarono in un primo tempo influssi greco-siriaci, poi, in età carolingia, influssi gregoriani.
Il proprio della Messa comprende, nell'ordine, l'Ingressa in luogo dell'Introito romano; il Salmello, l'Alleluia e il Cantus in posizioni analoghe a quelle dei romani Graduale, Alleluia e Tratto; il Post Evangelium; l'Offertorio; il Confrattorio (alla Frazione del Pane); il Transitorio in luogo del Communio. Salmello, Alleluia, Cantus e Offertorio sono dei responsori seguiti da uno o più versetti; gli altri canti sono semplici antifone a sezione unica.
Fra i numerosi canti dell'Ufficio citiamo i Lucernari, collegati col rito dell'accensione delle lampade durante i Vespri, e i Responsoria cum infantibus (responsori con l'intervento di un coro di fanciulli), assai caratteristici, dalla complessa struttura formale. Quest'ultimo canto è un esempio di una certa qualità spettacolare del canto ambrosiano, ravvisabile anche nella variata struttura degli Alleluia, che assegna ruoli specifici ai lettori, a un gruppo di fanciulli e al coro.
Sui libri liturgici ambrosiani la notazione musicale apparve molto tardi, praticamente non prima del XII secolo, in un'epoca in cui la tradizione ritmica era ormai morta; perciò la conoscenza della musica ambrosiana è limitata alla semplice melodia, che presenta elementi più arcaici rispetto al canto gregoriano, ma, insieme, ornamentazioni e amplificazioni assenti dal gregoriano, proprie di un'epoca più moderna. Ciò è dovuto al fatto che, non essendo mai uscito dall'ambito della Chiesa locale, l'ambrosiano non conobbe le codificazioni del canto gregoriano. Ad esempio sono estranee al canto milanese le forzature a cui fu soggetto il gregoriano per fare rientrare tutte le melodie nell'ambito dell'octoechos [oktòichos]; pertanto, la melodia ambrosiana presenta un andamento piuttosto libero e vario. Tipici sono pure i frequenti passaggi, all'interno dello stesso brano, dallo stile sillabico a quello più melismatico.