
TSM | Cronologia | Onomastico | Glossario | Thesaurus
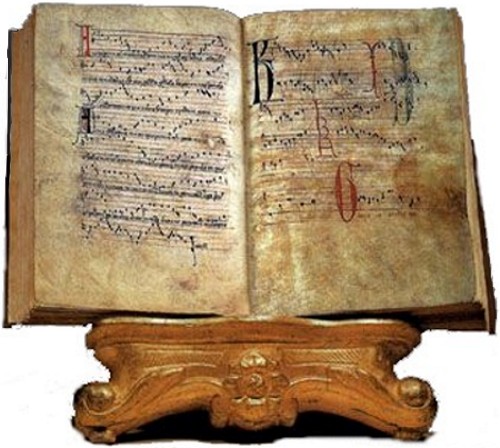
[Fino al xiii secolo] La teoria del ritmo è in notevole misura
meno trattata negli scritti medievali sulla musica rispetto alla harmonica, questo principalmente per i seguenti motivi:
–
innanzitutto il ritmo della musica medievale (anche strumentale) è
strettamente connesso al ritmo prosodico [...] trovando dunque lo studio del
ritmo la sua più appropriata sede nei manuali di grammatica;
–
[...] la ritmica medievale seguì un'evoluzione piuttosto lineare e non
conobbe complicazioni paragonabili a quelle della teoria armonica;
–
la teoria ritmica trovò inoltre nel De musica di Agostino una
sistemazione destinata a essere seguita per tutto il Medioevo [...]
Un grande cambiamento nell'orientamento della concezione del ritmo poetico riguardò il passaggio, verificatosi alla fine dell'età tardoantica, dalla prosodia basata sul metro quantitativo (determinato cioè dalla quantità della sillaba, la quale può essere lunga o breve) a una prosodia basata sul metro qualitativo (cioè determinato dall'accentazione delle sillabe).
Unitamente a questa radicale trasformazione la teoria ritmica musicale si separò in misura vieppiù maggiore dalla teoria del metro verbale, trovando una tarda cristallizzazione, nel Duecento, nel sistema dei modi ritmici.
Il processo che vede la prosodia svincolarsi dalla concezione quantitativa arcaica ha inizio nel periodo tardoantico, e più che in Agostino, fedele ai principi della teoria classica, lascia una traccia tangibile nel trattato De arte metrica di Beda il Venerabile (ca. 673-735).
Una spiegazione di questo fenomeno potrebbe venire dal fatto che con l'epoca tardo-antica l'analisi della prosodia andò basandosi più sulla lettura del testo scritto che sul suo ascolto [...].
Conseguentemente alla perdita del senso della quantità della sillaba, l'accento tonico assunse un ruolo fondamentale all'interno della successione delle sillabe nel definire i contorni metrici del verso, segnalandone l'unità ciclica all'uditore in funzione di elemento sensibile, soggetto al iudicium auris.
[...] La svolta così tracciata ricoprì un ruolo decisivo nell'economia della musica, nonché della poesia, occidentali: smarrita la concezione ritmica arcaica, legata ai cicli metrici, la musica rhythmica, con la mensurazione della durata delle note, diverrà nel Basso Medioevo una teoria finalizzata all'organizzazione del tempo musicale della composizione, sovvertendo uno dei principi fondamentali della concezione tradizionale della musica, cioè il suo essere preposta a liberare l'uomo dalla dimensione temporale esteriore, onde elevarlo alla dimensione atemporale dell'Arché, attraverso una temporalità musicale ciclica che mira a trasformare il tempo in spazio. [...]
Se la mensurazione non influenzò da subito il canto piano, pienamente calato nella dimensione ritmica arcaica, tuttavia nel giro di pochi secoli si registrò la scomparsa del canto piano e del repertorio gregoriano, assorbito nelle nuove composizioni polifoniche mensurate.
Se prima del xiii secolo i trattati di ritmica musicale sono ancora sporadici, a partire da allora i teorici prenderanno coscienza – quando la musica mensurata aveva già fatto non poca strada – della nuova concezione ritmica e si dedicheranno all'edificazione di una teoria che rendesse conto dell'organizzazione delle durate sonore, questo anche in vista dello sviluppo di una notazione ritmica precisa e adeguata alle esigenze della nuova pratica musicale affermatasi, il contrappunto. I trattatisti di quest'epoca matureranno la consapevolezza della radicale differenza tra la nuova pratica musicale mensurata e il cantus planus, arrivando a distinguere, con acuta coscienza storica, la prima come ars noua e la seconda come ars antiqua.
La funzione del tempo nella musica assume proprio dal Trecento una diversa connotazione rispetto ai secoli precedenti, divenendo materia di competenza del compositore, quando era precedentemente di dominio esclusivo dell'esecutore: il fattore temporale diventò così un parametro concettualmente e tecnicamente determinante nella composizione, quando prima era solo la condizione transeunte in cui si calavano i numeri musicali.
Nel XIII secolo si sentì l'esigenza di organizzare un sistema ritmico musicale indipendente da quello della prosodia poetica, arrivando così alla formulazione dei modi ritmici. Precedentemente a questo punto d'arrivo teorico, la scuola di Notre-Dame aveva dato una grande spinta allo sviluppo dell'organum e alla sua affermazione nel canto liturgico. I modi ritmici arrivarono dunque come tarda cristallizzazione teorica di consuetudini esecutive e compositive già largamente diffuse.
Il primo trattato in cui si fa loro menzione è il De musica mensurabili di Giovanni di Garlandia, scritto intorno al 1250. A prima vista i modi ritmici ricalcano gli schemi metrici della prosodia classica, ma in realtà derivano dalla ritmica poetica tardo-latina [...]. Il loro impiego nella musica mensurata del XIII secolo risente di una concezione ritmica che già può dirsi lontana dalla visione ciclica del tempo musicale. A rendere ancora più incerto l'inquadramento delle origini dei modi sta il fatto che i loro primi teorici (Girolamo di Moravia, Giovanni di Garlandia, Franco di Colonia e il cosiddetto Anonimo IV), attivi intorno alla metà del XIII secolo, non fanno alcun rimando al metro classico né utilizzano la nomenclatura dei metri classici per indicare i modi (semplicemente indicati con modus), diversamente da quanto avvenne con i modi melodici.
Possiamo credere che la genesi dei modi ritmici si inserisca nel quadro della ricerca bassomedievale di una teoria in cui risultassero fissati i capisaldi della pratica musicale, cercando nella formulazione di precise regole teoriche un linguaggio formale con cui il compositore potesse definire le sempre più complesse strutture musicali e rendere univocamente eseguibile la propria musica; in questo contesto i modelli classici giocarono quantomeno come traccia unificatrice.
La sistemazione dei modi ritmici riguardò precipuamente la polifonia e la musica strumentale, quest'ultima rimasta fino ad allora nell'ambito della trasmissione orale da esecutore a esecutore.
Vale la pena di sottolineare come i diversi domini della musica practica (canto piano, musica strumentale e prosodia) vadano in quest'epoca differenziandosi e specializzandosi a scapito della primitiva unità teorico-pratica della disciplina. La stessa distinzione di forme tra musica sacra e musica profana iniziò a divenire più netta: se per tutto l'Alto Medioevo fino al XIII secolo «la linea di demarcazione tra musica sacra e musica profana doveva rimanere incerta» (Reese, p. 219) ed essere la seconda influenzata e subordinata alla prima, in quel periodo la musica profana venne ad assumere tutte le caratteristiche della «musica d'arte» così come è concepita modernamente, e a trovare una dignità diversa, tutta legata alla nuova figura del compositore che si affermò nel Trecento.
La novità maggiore di questa trasformazione fu la perdita dell'inspiratio e della traditio quale momento fondamentale della pratica musicale, dinanzi alla crescente tendenza alla strutturazione e all'organizzazione 'calcolistica' della composizione, che assunse così caratteristiche del tutto nuove, acquisendo un'importanza tecnica fino ad allora sconosciuta e arrivando infine a corrompere con le sue innovazioni l'arte del canto sacro monodico.
Anche i trattati testimoniano di questa frattura tra i vari ambiti della musica, l'attenzione dei teorici spostandosi decisamente sul versante dell'ars mensurata, e l'interesse per il cantus planus – ormai visto come materia 'classica' – passando in secondo piano. È significativa l'apertura del trattato Ars cantus mensurabilis di Franco di Colonia:
Sempre nella teoria del XIII secolo, accanto ai modi ritmici, si fa avanti una nuova concezione dell'unità metrica, la quale porterà alla moderna organizzazione del ritmo in misure o battute. Ad essa si giunse partendo dalle due distinte posizioni circa la relazione tra ritmo e unità metrica esposte rispettivamente nei trattati di Giovanni di Garlandia e Franco di Colonia. Il primo concepisce il ritmo come il risultato della successione di elementi lunghi e brevi, il secondo lo intende come risultato dell'organizzazione in misure: «Il ritmo nel primo caso risulta dall'ordine degli elementi che lo costituiscono, le durate. Nel secondo caso è creazione di forme o ordine all'interno della successione di durate uguali, le perfezioni o misure» (Treitler 1979, p. 530). Evidentemente nessuno dei due autori fa riferimento alla metrica tradizionale [...]. Al più nella concezione di Giovanni è conservata traccia dell'antica nozione di quantità della sillaba come base del ritmo, quando Franco lascia aperta la porta alla possibilità di invenzione di qualsivoglia figurazione ritmica all'interno della misura.
La perfezione, cioè la cellula metrica composta da tre unità, è d'altra parte differente nei due autori: per Giovanni la lunga è composta da due brevi (¾ ® È È), come nella teoria classica, e conseguentemente la misura perfetta risulta composta da una lunga e una breve (¾ È); per Franco invece la lunga perfetta è misurata «con un accento, da tre unità di tempo» ed è dunque già perfetta in sé:
Da entrambi i trattati emerge poi una teorizzazione delle relazioni tra consonanze armoniche e tempi della battuta, ad esempio in Giovanni (De musica mensurabili, XI): «una nota dispari deve essere consonante con un'altra», e in Franco (Ars cantus mensurabilis, XI):«in tutti i modi [ritmici] le consonanze verranno poste all'inizio della perfezione, non importa se la prima nota sia una lunga, una breve o una semibreve».
Successivamente, nel XIII secolo, i teorici si sforzarono di riunire le definizioni di questi due autori, ma il tentativo era destinato a fallire già in partenza. La pratica andò invece evolvendosi in linea con la concezione di Franco, abbandonando definitivamente l'idea ritmica presente in Giovanni, la quale ancora aveva qualche punto di contatto con la concezione tradizionale. In questo modo «il ritmo è passato da una concezione basata sulla quantità a una concezione basata sulla perfezione» (Treitler, p. 531).
In realtà quello che restava della nozione quantitativa classica era dovuto a un compromesso con l'accentuazione delle sillabe. Il sistema dei modi ritmici, a ragion veduta definibile «misurato», ci sembra dunque il nesso che spiega come dall'antica pratica si sia giunti a un sistema in cui le proporzioni temporali si trovarono univocamente definite.
È sintomatico che i teorici dell'epoca abbiano voluto attribuire un significato simbolico alla misura perfetta del ritmo, appellandosi alle suggestioni offerte dal numero tre, numero dei tempi della longa perfecta. Tuttavia questo ricorso al simbolismo numerico, più che avere valore effettivamente simbolico, costituisce una giustificazione allegorizzante a posteriori, in quanto non fu posta a fondamento della teoria, bensì apparve solo tardivamente. Il teorico inglese trecentesco Walter Odington ci informa infatti che «in precedenza» la longa era intesa come misura binaria. Secondo Bukofzer:
Nonostante la buona volontà dei teorici, che scorgevano il riflesso della SS. Trinità nei tre tempi della perfezione, il rimando simbolico poteva essere tale solo se posto nella sua unità di modello atemporale (poiché i numeri musicali sono a priori dei fenomeni musicali stessi) e non ricavato a posteriori da una struttura astratta, quale risulta dal computo delle unità temporali.